di Joachim Kaiser
(Pubblicato sul n. 17 di Amadeus, aprile 1991)
Quanto l’incisione di un disco influenza lo stesso interprete al momento del concerto?
Può una versione impeccabile montata in studio servire alla chiarezza e alla verità interpretativa?
Sono quesiti importanti, per il tecnico, il critico, l’appassionato. Che possono comunque stare tranquilli:
i cattivi interpreti sono quasi sempre tali anche nelle registrazioni.
Dischi in carne e ossa
Ci si è chiesto sovente se per caso la perfezione discografica, realizzata artificialmente, non abbia abituato il pubblico a un certo standard che renda il virtuosismo un esercizio funambolico. È chiaro: chi come Jurgen Meyer-Josten mette intelligentemente a confronto non meno di ventidue versioni del Concerto per pianoforte di Schumann («Fono Forum», marzo 1964, p. 99 sgg.) si colloca in una situazione «artificiale» in senso negativo. Giacché prima dell’invenzione del disco non era immaginabile un concatenamento di circostanze che rendesse possibile o doveroso ascoltare ventidue volte lo stesso pezzo eseguito da interpreti diversi in un brevissimo spazio temporale.
Confronti funambolici
Oggi le riviste discografiche traboccano di questi confronti. (Un pianista che studia il concerto lo suona di sicuro più di ventidue volte, ma assomiglia più a uno scultore con lo scalpello che a un osservatore con lo sguardo costantemente fisso). Naturalmente alla fine Jurgen Meyer-Josten non sa più per chi decidersi, a dispetto di tutti i vari Gieseking, Lipatti, Richter, Rubinstein, Cortot e molti altri ancora. Inizia la sua rassegna così: «22 per (op.) 54 = 0 purtroppo questa è la mia constatazione, poiché il conto artistico non torna, il risultato è deludente… Non ho ancora sentito in disco una versione ideale sotto ogni aspetto del Concerto di Schumann. E neppure in una sala da concerto».
 Il critico descrive poi le ventidue incisioni e giunge a una conclusione che dimostra dove può condurre la libera disponibilità di spazio e di tempo, l’ubiquità di ascolto del disco: «Peccato non esista un’incisione del Concerto di Schumann realizzata da Wilhelm Fürtwängler, Edwin Fischer (nel suo periodo migliore) e la Filarmonica di Berlino. Forse sarebbe stata la versione ideale».
Il critico descrive poi le ventidue incisioni e giunge a una conclusione che dimostra dove può condurre la libera disponibilità di spazio e di tempo, l’ubiquità di ascolto del disco: «Peccato non esista un’incisione del Concerto di Schumann realizzata da Wilhelm Fürtwängler, Edwin Fischer (nel suo periodo migliore) e la Filarmonica di Berlino. Forse sarebbe stata la versione ideale».
Queste asserzioni di un ascoltatore di dischi «professionista» indicano un eccesso. Tuttavia è agli estremi che le conseguenze diventano più evidenti e significative. Supponiamo che qualcuno come Meyer-Josten – quindi un ascoltatore di dischi ugualmente appassionato, un critico di notevole esperienza – assista a un’esecuzione in concerto del brano in questione. Come si porrà di fronte a ciò che gli viene presentato? Non gli sfuggirà alcuna stonatura, così come a un pianista che conosce il brano a memoria. Con ogni probabilità però giudicherà troppo ovvia la «perfezione», la mancanza di stonature. Non ha mai provato a suonare quel brano, non conosce la difficoltà necessaria per impararlo e comunque non sa quanto sia facile che, durante l’esecuzione, qualcosa vada storto. In altre parole, il collezionista di dischi diviene troppo indifferente nei confronti dell’«esattezza» e, nel contempo, troppo esigente per quanto riguarda le stonature.
La conseguenza di un simile atteggiamento è paradossale: non si tratta di sopravvalutare bensì di sottovalutare il virtuosismo manuale. Si è a tal punto assuefatti all’«esatto» da non accorgersene nemmeno. A ciò corrisponde la differenza fra il medio e il mediocre, che nella pratica di ascolto discografico non è più palese. Oggi, anche il pianista poco dotato non mette più sul mercato i dischi incisi con così tanti errori da travisare il senso del pezzo, e un pianista di media levatura non può fare altro che suonare lo stesso concerto con molta cura musicale e attenzione per la tecnica. Il disco occulta le energie che hanno portate al superamento delle difficoltà tecniche.
È per questo che alcuni passa tempi manuali, per esempio i brani scritti per la sola mano sinistra, non hanno alcun effetto sul disco (se poi hanno un qualche effetto musicale!). Non si vede il limite estremo e neppure lo sforzo necessario a superarlo. Da ciò deriva una conseguenza inimmaginabile per i detrattori dei dischi.
Esattezza e verità
Il virtuosismo, che in concerto suscita piuttosto spesso una (giusta) ammirazione come puro esercizio di forza, nel disco resta privo di significato qualora sia fine a se stesso e non esprima anche un radioso senso di vita, un superbo impegno dell’anima.
Le note di Vladimir Horowitz non sono più esatte né più veloci di quelle incise da Byron Janis, eppure le si ascolta più ammaliati, poiché la loro «esattezza» è confortata dalla verità di un temperamento pianistico scatenato. Al suo confronto non ha importanza che anche Byron Janis e Van Cliburn non facciano errori nei loro dischi! Dunque il disco allontana dal virtuosismo, lo nasconde in quanto presupposto. Ma così dovrebbe essere, nel senso di custode del Grâl puramente musicale. Anche le manipolazioni più raffinate però non possono fare di un pianista tecnicamente debole un pianista di rango. Certo, vi sono incisioni che nessuno ha effettivamente mai suonato. Una variazione dopo l’altra è stata ripetuta così tante volte fino a che la quantità di suoni esatti è risultata sufficiente per cucire una versione impeccabile. Ci sarebbe poco da obiettare contro la sostituzione di un passaggio infelice, sebbene il montaggio sia quasi sempre privo della tensione che può avere una versione omogenea. Inoltre, il costo della sala d’incisione dei concerti con l’orchestra è troppo elevato perché si possano concedere a un pianista scadente le settimane necessarie. Ne consegue un dato di fatto tranquillizzante: i cattivi pianisti restano tali anche nell’incisione. I critici di tutti i tempi e tutti i paesi possono senz’altro segnalare innumerevoli errori, imprecisioni, difetti di articolazione non solo nei vecchi dischi di gommalacca, che dovevano venire incisi tutti d’un fiato, ma anche in quelli prodotti e manipolati oggigiorno.
 In occasione di una critica assai acuta sui dischi di Sergej Rachmaninov, l’intelligente pianista Alfred Brendel (nonostante si sia risparmiato, nella «stroncatura» della Sonata «Marcia funebre» di Chopin eseguita da Rachmaninov , argomenti circostanziati sui primi due movimenti) ha descritto le debolezze di alcune incisioni pianistiche forzate in maniera elettroacustica: «Sto ancora aspettando un esperto che mi spieghi perché il suono pianistico di Cortot o di Edwin Fischer venne riprodotto nei dischi “storici” degli anni Trenta in modo più fedele rispetto a tutte le incisioni del dopoguerra. Si ha l ‘impressione di star seduti in un bel posto in una buona sala. Si percepisce il timbro personale. Invece, come ascoltatore di parecchie incisioni ad alta fedeltà, ci si trova improvvisamente seduti dentro al pianoforte a coda o sopra di esso o persino appesi da qualche parte, sotto il soffitto» («Phono», Vienna, anno VIII, n. 6, p. 117 sgg.). Brendel ha certamente ragione in questa critica sulle incisioni che mettono al «Servizio» della musica tutte le possibili raffinatezze elettroacustiche e riescono solo a non far più sembrare il pianoforte usato per l’incisione un pianoforte terrestre. D’altro canto, appartiene alla patina delle incisioni «Storiche» il rispecchiare in modo stentato l’individualità del suono pianistico di Rachmaninov , Cortot o Schnabel. Questi dischi non pretendevano di sostituire la realtà musicale. In ciò si manifestava un’imperfezione, ma anche un vantaggio. Non si era minimamente tentati di identificare la musica riprodotta con quella eseguita in concerto. In un contesto molto diverso, Karl Kraus – lagnandosi del fatto che nel 1908 Alexander Girardi abbandonò Vienna per Berlino – ha esaltato questa qualità, in qualche modo «Straniante», del disco: «A noi viennesi restano, quale testimonianza del nostro amato Alexander Girardi, solo un paio di dischi grammofonici. Fu abbastanza patriota da cantarci qualcosa prima del suo trasferimento. Talvolta riascolto i vecchi Lieder, poiché se risuonano sempre come l’addio di una maestà in declino, adesso il rumore della vita catturata dalla macchina dà loro un suono di terribile commozione».
In occasione di una critica assai acuta sui dischi di Sergej Rachmaninov, l’intelligente pianista Alfred Brendel (nonostante si sia risparmiato, nella «stroncatura» della Sonata «Marcia funebre» di Chopin eseguita da Rachmaninov , argomenti circostanziati sui primi due movimenti) ha descritto le debolezze di alcune incisioni pianistiche forzate in maniera elettroacustica: «Sto ancora aspettando un esperto che mi spieghi perché il suono pianistico di Cortot o di Edwin Fischer venne riprodotto nei dischi “storici” degli anni Trenta in modo più fedele rispetto a tutte le incisioni del dopoguerra. Si ha l ‘impressione di star seduti in un bel posto in una buona sala. Si percepisce il timbro personale. Invece, come ascoltatore di parecchie incisioni ad alta fedeltà, ci si trova improvvisamente seduti dentro al pianoforte a coda o sopra di esso o persino appesi da qualche parte, sotto il soffitto» («Phono», Vienna, anno VIII, n. 6, p. 117 sgg.). Brendel ha certamente ragione in questa critica sulle incisioni che mettono al «Servizio» della musica tutte le possibili raffinatezze elettroacustiche e riescono solo a non far più sembrare il pianoforte usato per l’incisione un pianoforte terrestre. D’altro canto, appartiene alla patina delle incisioni «Storiche» il rispecchiare in modo stentato l’individualità del suono pianistico di Rachmaninov , Cortot o Schnabel. Questi dischi non pretendevano di sostituire la realtà musicale. In ciò si manifestava un’imperfezione, ma anche un vantaggio. Non si era minimamente tentati di identificare la musica riprodotta con quella eseguita in concerto. In un contesto molto diverso, Karl Kraus – lagnandosi del fatto che nel 1908 Alexander Girardi abbandonò Vienna per Berlino – ha esaltato questa qualità, in qualche modo «Straniante», del disco: «A noi viennesi restano, quale testimonianza del nostro amato Alexander Girardi, solo un paio di dischi grammofonici. Fu abbastanza patriota da cantarci qualcosa prima del suo trasferimento. Talvolta riascolto i vecchi Lieder, poiché se risuonano sempre come l’addio di una maestà in declino, adesso il rumore della vita catturata dalla macchina dà loro un suono di terribile commozione».
Ma non sono forse danneggiati dall’evoluzione discografica quegli artisti che si arrovellano sul disco e sulla sua eco nella consapevolezza e nelle abitudini d’ascolto del pubblico? Chi come Claudio Arrau o Arthur Rubinstein ha continuato con voglia ed energia a dare concerti, incidere dischi, persino a registrare lo stesso brano più volte e secondo differenti angolazioni, considera la cultura nastrografica e discografica un piacevole, stimolante arricchimento della cultura concertistica.
Non tutti gli artisti, però, ci riescono. Per taluni virtuosi esiste davvero quel fantasma che sta fra loro e il pubblico quando entrano nella sala da concerto: il disco. Lo temono, non sono capaci di sfuggirgli, perché il fantasma è rappresentato da loro stessi. Cominciare a suonare sapendo che il pubblico ha nelle orecchie il proprio disco è ancora peggio del sapere che la propria prestazione e individualità sarà confrontata con la perfezione discografica o l’interpretazione di un collega! Alcuni hanno già assicurato, lamentandosi, che ciò rappresenta uno sforzo pressoché sovrumano. I dischi creano aspettative precise. Chi ha ascoltato una dozzina – se non decine – di volte la registrazione di Wolfgang Schneiderhan del Concerto per violino di Beethoven conosce a memoria nota per nota come Schneiderhan suoni quel concerto. E quindi deduce che Schneiderhan eseguirà il brano in concerto proprio nello stesso modo, o almeno non con minor brillantezza, purezza di suono e perfezione. Anche se questa aspettativa resta inconscia, comunque c’è. Ogni anomalia, ogni magagna, ogni impurità – inevitabili in un concerto a causa delle condizioni non sempre ottimali – viene sentita come un peggioramento. Allora, per i virtuosi, il disco è una prigione; li rende insicuri e confusi, li induce a imitarsi, fino a diventare loro stessi dischi in carne e ossa, cosa che segna la morte della libertà artistica.
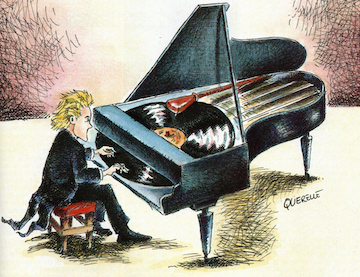 Fra documento e interpretazioni
Fra documento e interpretazioni
Solo la disinvoltura può esorcizzare questo fantasma. Una disinvoltura che Wilhelm Fürtwängler, la cui lotta contro gli apparecchi d’incisione era proverbiale, non possedeva. Egli non aveva né la capacità né il desiderio di interessarsi al mondo della tecnica (a eccezione, è ovvio, della tecnica musicale). Anche se il disco permette di esprimersi secondo modalità più convincenti ed esatte rispetto a un’esecuzione dal vivo. Una volta, Karl Böhm ha sottolineato che alla fine di ogni recita di Elettra la cantante protagonista «è stanca e l’orchestra suona naturalmente troppo forte» . In sede d’incisione, invece, si potrebbe non solo «aprire» il microfono verso Elettra, così che la sua voce sia ben udibile e persino comprensibile al di sopra dello strepito orchestrale, ma si potrebbe pure incidere i difficili passi conclusivi quando la cantante è ancora fresca. Allora il disco è molto più di un puro e semplice documento, come lo era la «patina colorata» delle incisioni storiche. Allora, non è nemmeno più un aiuto per coloro che soffrono di «Sindrome da pubblico» e non riescono a dare il meglio di sé in concerto per agitazione e imbarazzo, ma un mezzo interpretativo indipendente. E sottovalutare la fatica che per incidere il disco è costata, la sua storia, i suoi contributi, l’importanza dei suoi risultati, sarebbe non solo incompleto ma addirittura ingiusto.
Oggi ogni musicista dedica al disco una parte delle sue energie, della sua arte e della sua serietà. Nella seconda metà del ventesimo secolo non vi sono più carriere pianistiche senza disco. Esiste una tensione produttiva tra la cultura concertistica e il disco; sarebbe un segno di sordità mettere a tacere quest’ ultimo.
******
Joachim Kaiser, uno dei più insigni studiosi tedeschi, dal1959 è critico musicale della Süddeutschezeitung; dal 1977 è professore alla Ochschule per la musica e l’arte drammatica di Stoccarda. Per gentile concessione dell’autore pubblichiamo queste pagine da «Grandi pianisti del nostro tempo», ed. Piper-Schott.
Le illustrazioni sono di Norman Rockwell.






