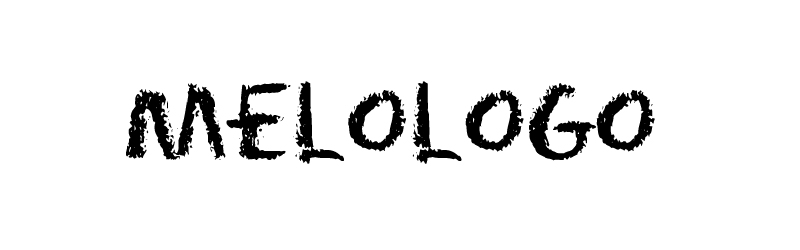di Carlo Delfrati
Amadeus n. 5 aprile 1990: ha inizio la pubblicazione della rubrica “Le Parole della musica” a cura di Carlo Delfrati, uno dei maggiori esperti in didattica musicale e autore di diffusissimi corsi per le scuole medie.
Con questa rubrica si è cercato di chiarire il significato di alcuni dei più frequenti (ma anche dei più insoliti) termini usati dagli addetti ai lavori.
La rubrica Parole della musica si protrae fino al n. 73 del dicembre 1995 e viene sostituita dalla rubrica Scuola cui farà seguito il supplemento ScuolAmadeus.
Gian Giacomo Rousseau, il pedagogista e filosofo, occupa un suo pur piccolo spazio nella storia della musica. I manuali ne ricordano la partecipazione alla querelle des bouffons, in cui parteggiava appassionatamente per il melodramma napoletano, contro il «manierismo» dell’opera francese: fino al punto di cimentarvisi in proprio e di comporre secondo il gusto napoletano Le devin du village. Dieci anni dopo, nel 1762, scrive per il teatro di prosa una «scena lirica», Pigmalione. Gli piacerebbe metterla in musica. Ma poiché la sua vita ha preso ormai una direzione tutta diversa, preferisce affidare il compito a un musicista «a tempo pieno», tale Horace Coignet (di proprio pugno Rousseau si prende l’uzzolo di inserire un paio di brani. Il lavoro che ne nasce, nel 1770, ha un aspetto singolare: i personaggi non cantano, come nell’opera tradizionale, ma parlano; la musica è inserita fra un dialogo e l’altro, a mo’ di commento, di ambientazione psicologica ed evocativa. Questa pratica ha precedenti antichi. Il più vicino è quello del teatro che alterna brani parlati e brani cantati, il Singspiel tedesco o la ballad opera inglese. Ma solo dopo il successo del Pigmalione si afferma il nuovo genere, in cui i dialoghi sono solo parlati. Il primo a riproporlo con partiture di tutto rispetto, sarà il boemo Jiri Benda, con la sua Ariadne, rappresentata nel 1775. Il risultato è ben diverso da quello della musica idolatrata da Rousseau, il melodramma napoletano. Ma che Rousseau si sentisse ancora affettivamente legato, lo lascia intuire il fatto che usava chiamare mélodrame (adattando la parola italiana) anche il nuovo genere. Il nome passa in altri paesi tale e quale, salvo l’adattamento fonologico: in Germania diventa Mélodram; in Inghilterra melodrama In questi paesi l’opera lirica era rispettivamente chiamata… Oper e opera (in Francia opéra): quindi nessun rischio di confusione. Le cose si complicano invece nell’uso italiano: da noi melodramma è il teatro cantato e «melodrama» è solo un errore d’ortografia. E infatti ogni tanto da noi qualcuno casca nel tranello, e scrive che Benda è l’autore del «melodramma» alias opera lirica, Ariadne.
Bisogna correggere: Benda ha composto un melodrama con un’emme sola (per giustizia, bisogna aggiungere che Benda è autore anche di un melodramma, con due emme). Il garbuglio è sufficientemente irritante, da consigliare lo scrittore italiano di cose musicali a lasciare la parola melodramma, nella sua originaria e corretta ortografia, al teatro cantato; quindi a inventare una parola nuova per il teatro di prosa con commenti strumentali. Eccola: melologo.
Dunque il melologo prende il volo con Jiri Benda, per passare subito a mani più famigliari: Mozart inserisce melologhi nella sua Zaide, Weber nel Franco cacciatore, Berlioz nel Lélio, Cherubini in Le due giornate, Beethoven nel Fidelio, nel Re Stefano, nell’Egmont. La pratica varca il palcoscenico. Si moltiplicano, dopo d’allora, pagine strumentali scritte per accompagnare recitazioni parlate di testi. Franz Schubert scrive nel 1826 Abschied: il testo del poeta Pratobevera è declamato sopra un accompagnamento continuo del pianoforte. Lo stesso fa vent’anni dopo Robert Schumann col suo melologo Schön Hedwig. Poi Liszt, Wagner, Humperdinck, fino ad arrivare ai compositori del nostro tempo, da Stravinskij, con la sua Perséphone, a Henri Pousseur. Nell ‘Italia del melodramma (con due emme) il genere non gode dello stesso successo. Ma almeno alcuni momenti restano indimenticabili: «Teneste la promessa … la disfida ebbe luogo; il barone fu ferito però migliora…» E poi: «Cessarono gli spasimi del dolore…». O ancora: «Ebbene… che vuol dire quell’andare e venire, quel guardarmi così…» .
Momenti indimenticabili proprio perché così insoliti nel nostro costume teatrale. Quando le più amate eroine di Verdi e Puccin muoiono, gli autori sembrano presi da un «pudore belcantistico»: lasciano arie – vocalizzi, e abbandonano i protagonisti alla straziante nudità della voce che parla o che geme, o che grida. Anche questi sono casi di monologo. O forse dovremmo dire, di «melodrama nel melodramma».
(Amadeus n. 65 aprile 1995)