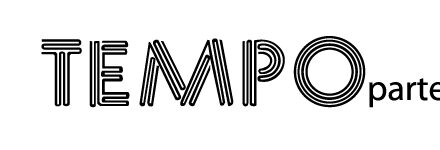di Carlo Delfrati
Amadeus n. 5 aprile 1990: ha inizio la pubblicazione della rubrica “Le Parole della musica” a cura di Carlo Delfrati, uno dei maggiori esperti in didattica musicale e autore di diffusissimi corsi per le scuole medie.
Con questa rubrica si è cercato di chiarire il significato di alcuni dei più frequenti (ma anche dei più insoliti) termini usati dagli addetti ai lavori.
La rubrica Parole della musica si protrae fino al n. 73 del dicembre 1995 e viene sostituita dalla rubrica Scuola cui farà seguito il supplemento ScuolAmadeus.
La storia della musica a programma inizia proprio con la musica stessa. Le musiche tribali sopravvissute nel presente, se vogliamo farle valere come testimonianza di un passato lontano, sono sempre alle prese con eventi esterni d’ogni genere, con esseri naturali o soprannaturali: insomma quelle «idee extramusicali» che la nostra manualistica considera tipiche della musica a programma. In Europa, i primi esempi si è soliti cercarli nelle cacce medievali, quindi nei pezzi rinascimentali che hanno per oggetto battaglie (a partire da quella di Janequin), canti d’uccelli, eventi naturali, umane avventure. Da allora la tradizione non s’interrompe, affiancandosi a quella delle musiche prive di riferimenti realistici e prive anche di destinazioni che non siano il puro «diletto dell’udito»: la musica «pura», appunto, o «assoluta». Kuhnau e Couperin raccontano sulla tastiera lunghe storie, sacre o profane. Fra l’Otto e il Novecento, i poemi sinfonici di Liszt e di Smetana, di Strauss e Sibelius e Respighi mettono a disposizione del programma le risorse della moderna orchestra sinfonica. Su cosa si fonda, la capacità della musica di modellarsi su un programma? Nemmeno gli autori più refrattari possono sottrarsi al riconoscimento elementare: «Esiste una certa cerchia di idee che la musica può rappresentare nelle più ampie proporzioni con i suoi mezzi più propri -sostiene il loro caposcuola, Edward Hanslick -Sono tutte quelle idee che si riferiscono immediatamente a variazioni acustiche della forza, del movimento, delle proporzioni, cioè le idee del crescere, diminuire, affrettare, ritardare, dell’intreccio complicato, della semplicità del procedere ecc… Il movimento costituisce il tratto che la musica ha in comune con gli stati affettivi, e a cui essa, con la sua forza creatrice, può dar forma in mille gradazioni e contrasti».
A questa disponibilità del flusso sonoro a «mimare» il movimento e il tempo, se ne aggiunge una ancora più elementare, che ritroviamo come ingrediente essenziale nelle opere a programma: l’onomatopea la possibilità di imitare suoni e rumori. Un rullo di timpani può ben imitare lo scoppio di un tuono. Ma lo approfondiremo un’altra volta. Per ora fermiamoci a considerare un apparente paradosso. Il musicologo individua normalmente nella forma complessiva della composizione lo spartiacque tra musica a programma e musica assoluta: la musica assoluta sarebbe quella che rispetta «regole strutturali intrinseche» (per esempio le regole della forma-sonata); l’altra invece seguirebbe le regole imposte dal programma (per esempio il ritorno ossessivo di un motivo, come «presenza incombente del sultano» di Sheherazade). Purtroppo le cose non sono così semplici. Se una musica a programma del tardo Ottocento o del primo Novecento elude gli schemi della forma-sonata, non è perché vi è costretta dal programma, ma perché diverse sono le regole formali di quel tempo. Tanto è vero che le ritroviamo anche in sinfonie coeve prive di programma, poniamo la Quinta di Mahler. Viceversa, quando un autore dell’età barocca o classica si cimenta con la «descrizione di una battaglia», come fanno Biber o Neubauer, il «contenitore» dentro il quale marciano i loro eserciti non è altro che il codice di regole proprio del concerto barocco o della forma-sonata, rispettivamente. È questo che spiega l’enorme differenza fra un temporale sentito da Vivaldi, uno sentito da Beethoven e uno sentito da Ferde Grofè. Ma ancora una volta, ciò non ci autorizza a concludere che la musica in fin dei conti non ha a che fare con «l’esterno».
La conclusione corretta è probabilmente un’altra: che l’esterno non è mai «fonografabile» oggettivamente, ma può essere sentito solo con le orecchie della propria cultura di appartenenza; e, di nuovo, che la distinzione tra i due generi, se proprio non sparisce, si fa sempre più labile. Soprattutto, non si presta a servire da di scriminante, per distribuire premi o censure.
(Amadeus n. 57 agosto 1994)