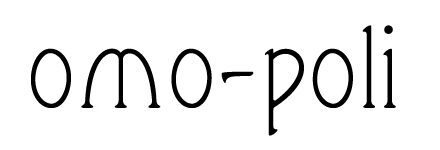di Carlo Delfrati
Amadeus n. 5 aprile 1990: ha inizio la pubblicazione della rubrica “Le Parole della musica” a cura di Carlo Delfrati, uno dei maggiori esperti in didattica musicale e autore di diffusissimi corsi per le scuole medie.
Con questa rubrica si è cercato di chiarire il significato di alcuni dei più frequenti (ma anche dei più insoliti) termini usati dagli addetti ai lavori.
La rubrica Parole della musica si protrae fino al n. 73 del dicembre 1995 e viene sostituita dalla rubrica Scuola cui farà seguito il supplemento ScuolAmadeus.
«Pessima nomea ha il pedale. Le libertà che la gente vi si prende sono assolutamente riprovevoli». Ferruccio Busoni, a cui si devono queste parole, si riferiva al cattivo uso del pedale del pianoforte, quel pedale di destra che permette al suono di continuare anche quando il tasto è abbandonato. L’effetto di confusa risonanza che si crea è tanto gradito al principiante, che può così nascondere le sue magagne. Questa pratica permette di appioppare al povero pianista il facile e spietato calembour «suona coi piedi».
I pianisti che del pedale fanno un uso saggio non si allarmino: l’espressione «Suonare coi piedi» non nasce dalla pratica musicale, ma dall’ingrato disprezzo che l’umanità ha elaborato per le sue estremità inferiori: si dice fatto «coi piedi» o «pedestre» tutto quel che è fatto male. Anzi proprio il musicista (insieme al calciatore e a pochi altri) potrebbe concorrere a nobilitare l’arto ingiustamente vilipeso: solo coi piedi infatti è possibile agire sulla tastiera inferiore del1’organo, quella dei suoni più gravi: la pedaliera, appunto. Solo coi piedi è possibile gettare le fondamenta armoniche delle più solenni composizioni organistiche. Suoni gravi, a lungo tenuti mentre sulle tastiere manuali le dita dell’esecutore svolgono la trama di canti e controcanti: i francesi chiamano questi lunghi suoni gravi points d’argue, i tedeschi Orgelpunkte, punti d’organo, dove «punto» sta per fermata, fermata del suono. E in italiano? La nostra lingua va più al sodo: il lungo suono grave viene identificato con l’oggetto che lo produce, e viene chiamato dunque pedale! Da qui in poi, dobbiamo fare attenzione agli usi del termine: se si parla di strumenti, pedale è un aggeggio meccanico; se si parla di composizioni, pedale è un suono tenuto, in un insieme polifonico. Uno dei primi esempi lo troviamo nel Capriccio pastorale di Frescobaldi: Pedali porta scritto l’edizione a stampa del 1637, accanto alle lunghe note che introducono il pezzo e lo accompagneranno con poche interruzioni fino alla fine. Il pedale crea un clima raccolto, una sensazione di staticità, di fondamento stabile.
È per questo che lo troveremo spesso, dall’età barocca in poi, quando l’autore vuole in qualche modo «fermare il tempo», bloccare l’imprevedibilità del discorso musicale. Lo troveremo nelle sezioni finali d1 tante pagine di Bach, ad anticipare solennemente l’affermazione conclusiva. Lo troveremo in Ciaikovskij a rinforzare quel senso di stasi angosciosa che caratterizza il suo mondo espressivo. Le pagine di Ciaikovskij sono orchestrali. L’uso del pedale (del suono tenuto) passa infatti dall’organo ai complessi strumentali. E allora è facile scoprire che se il termine pedale nasce con la musica per organo, la pratica è molto più antica. Ce lo fa capire lo stesso Capriccio pastorale di Frescobaldi. Perché «pastorale»? Perché richiama la musica dei pastori, quella delle zampogne. E sappiamo bene come è fatta una zampogna: canne con i fori per suonare una melodia, e canne che producono una nota sola, più grave, risonante insieme alle altre: un pedale appunto. La pratica del pedale si perde dunque nella notte dei tempi. Altri strumenti funzionavano (e funzionano) allo stesso modo. Pensiamo solo allo scaccia-pensieri: una linguetta di metallo che produce sempre e solo quel suono. Ma se facciamo bene attenzione, scopriamo che, sopra quel suono-base, i movimenti della bocca permettono di disegnare (con i suoni armonici) un’intera scala musicale, quindi una qualunque melodia. È così che Johann Georg Albrechtsberger, maestro di Beethoven, ha potuto lasciarci un simpatico concerto per scacciapensieri e orchestra. Naturalmente qui il pedale è obbligato e inevitabile.
È forse da quest’uso strumentale che deriva il pedale vocale conosciuto un po’ da tutte le culture, non solo in quella europea. In Europa questa pratica è alle origini della polifonia, fin dal IX secolo. E qui avviene un fatto curioso, che dimostra come quello delle parole sia un vero e proprio campo di battaglia (quello delle parole è un campo che si apre con le metafore, ma spesso trasferisce la contesa ai cannoni). Il primo genere polifonico si chiama organum. Tutto sembra quadrare: organum viene dal suono grave tenuto (ossia dal pedale), e questo è prodotto dal pedale dell’organo. Ma si dà il caso che gli organi costruiti almeno fino al 1100 potevano produrre un suono solo per volta, quindi non consentivano la polifonia, quindi – conclude la maggioranza dei musicologi – non erano affatto legati alla pratica degli organa. Lasciamo i musicologi nella loro dotta arena, per ricordare che un pedale è anche capace di trasmigrare. Nato come suono grave, al basso, un pedale può trovarsi, fin dall’età barocca, nella regione melodica centrale, o addirittura in quella acuta. È così, con un pedale sovracuto, che Borodin c’introduce al ciclo delle sue Steppe dell’Asia Centrale. Ed è così che il musicista, proiettando negli spazi nobili, quelli superiori, un evento nato originariamente in quelli inferiori, «pedestri», ci fornisce una metafora per la riabilitazione del più umile e servizievole fra i nostri segmenti corporei.
(Amadeus n. 44 luglio 1993)