di Harvey Sachs
(Pubblicato sul n. 12 di Amadeus, novembre 1990)
Il fenomeno Gould fra genio e puerilità.
A proposito di un mito del nostro secolo. Bizzarro, malinconico, ossessivo,
ma anche geniale talento interpretativo: attraverso le registrazioni trasmesse in tv
Glenn Gould è stato finalmente presentato al pubblico italiano.
Un celebre pianista della generazione nata tra le due guerre mondiali ha raccontato di essere stato portato, all’età di sei anni, a un concerto di Josef Hofmann, uno dei più grandi virtuosi della generazione precedente. «Mi fece un’impressione schiacciante – ricorda il pianista «Spettatore» – e quando mi riportarono a casa, in macchina, mi trovavo in quel meraviglioso stato di dormiveglia in cui uno si sente passare per il cervello ogni sorta di suono incredibile. Erano tutti suoni orchestrali, ma io li suonavo tutti, e improvvisamente io ero Hofmann. Rimasi incantato».
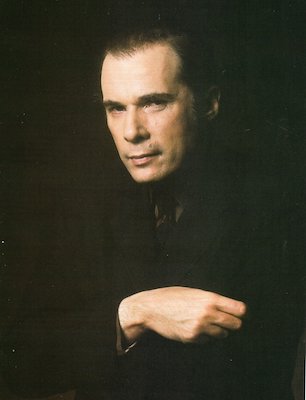
Glenn Gould
La storia dell’interpretazione musicale è piena di racconti come questo, in cui un ragazzino o una ragazzina che ha appena iniziato gli studi assiste a una esibizione di un grande artista, ne subisce il fascino e poi continua a seguire quella stessa strada per il resto della vita.
L’aspetto particolare di questo racconto è che il ragazzino si chiamava Glenn Gould, il quale, non appena stabilita la propria reputazione pianistica a livello mondiale, si sarebbe ritirato per sempre dalle sale da concerto e quindi da qualunque tipo di contatto diretto con i ragazzi delle generazioni successive.
In Europa la vera, grande popolarità di Gould è cominciata soltanto dopo la morte del pianista, avvenuta nel 1982 a Toronto, dove era nato cinquant’anni prima e dove aveva compiuto tutti i suoi studi musicali. Negli otto anni trascorsi da allora, in Francia, in Italia e in Germania c’è stata quasi una inondazione «gouldiana», prima di libri e ora di registrazioni, ripulite e ripubblicate su compact. Recentemente la terza rete della Rai gli ha dedicato una serie di trasmissioni che, malgrado l’orario strano (prima la serie è stata collocata dopo la mezzanotte – involontario omaggio al nottambulo Gould – poi è stata ripresa dopo le tredici), sono riuscite a suscitare molto interesse da parte della stampa e, speriamo, anche del pubblico. Nel Vecchio Continente, insomma, il momento di Gould è arrivato.
In Nordamerica Gould stava diventando un mostro sacro già nel 1956, l’anno in cui si pubblicò la sua prima registrazione per la Columbia Records (CBS): le Variazioni «Goldberg” di Bach. Ne conservo tutt’ora la mia copia, ormai molto rovinata, che porta in copertina una sequenza di trenta fotogrammi del pianista ventitreenne, scattati nello studio durante le sedute di registrazione: Gould suona, canta, gesticola, chiacchiera col produttore, esamina le viscere del pianoforte e a volte sembra quasi ballare con lo spartito. Ci sono anche le note di copertina scritte da Gould – lo stesso miscuglio di trovate brillanti e pseudofilosofia puerile che avrebbe caratterizzato anche la maggior parte dei suoi scritti successivi. Ma non dimentichiamo il disco stesso, che contiene una delle più geniali ed esilaranti interpretazioni musicali mai incise; ci sono tanti punti discutibilissimi, senza dubbio, ma accanto a questa versione tutte le altre, precedenti e successive, col clavicembalo o col pianoforte, compresa quella che lo stesso Gould avrebbe fatto venticinque anni dopo, mi sembrano molto, ma molto pallide.
Un grandissimo talento
Gould faceva parlare di sé in America nella seconda metà degli anni Cinquanta e nella prima metà degli anni Sessanta per gli stessi motivi per i quali si parla di lui oggi in Europa (e, ancora e sempre, in America): per i musicisti e i veri intenditori era un grandissimo talento che a volte riusciva a illuminare un pezzo come pochissimi altri musicisti; per i meno coinvolti apprezzatori di cose musicali era un personaggio bizzarro che valeva la pena di vedere, non solo di sentire ma, ammettiamolo, anche i musicisti trovavano attraente questo lato del «fenomeno Gould», sia in senso positivo che in senso negativo. Ho già raccontato in altra sede (La Stampa, 29.3.90, n.d.r.) come, da liceali nella città di Cleveland, nell’Ohio, nei primi anni Sessanta, io e i miei amici musicomani aspettavamo l’annuale arrivo di Gould con insolita impazienza. Questi faceva il suo ingresso in palcoscenico con l’aspetto di uno che si trascina verso il patibolo e fissava stordito il pubblico. Cantava e grugniva mentre suonava, intrecciava le gambe sotto la tastiera e a volte quasi appoggiava la testa sui tasti; faceva dei gesti strani quando aveva un braccio libero, e a pezzo finito s’inchinava goffamente al pubblico mentre cercava di rimettere le code della camicia dentro ai pantaloni. Ma con i suoi imponenti mezzi tecnici e cognitivi riusciva a portarci, per vie nuove e a tratti allarmanti, dentro le strutture create dai suoi compositori prescelti:

Glenn Gould in uno degli atteggiamenti tipici della sua straordinaria personalità.
Ricordo un concerto del 1962 che comprese il Concerto in re minore di Bach e il Concerto in do minore di Beethoven: ebbi la sensazione di aver vissuto parecchi anni di istruzione in meno di un’ora.
Ricordo anche una conferenza tenuta da Gould nel 1961, nel corso della quale il Quartetto «Symphonia», composto da bravissimi elementi dell’orchestra di Cleveland, eseguì per la prima volta in assoluto un quartetto per archi scritto dallo stesso Gould. L’avvenimento era stato organizzato dal Women’s Committee dell’orchestra, un comitato di donne per bene che racimolavano soldi per l’orchestra. Il quartetto di Gould – almeno come lo ricorda uno che allora aveva quindici anni – era un esercizio di ortodosso serialismo schoenbergiano e prima di farlo sentire Gould tenne un discorso informale sulla storia della dodecafonia, intervenendo ogni tanto sulla tastiera per dimostrare qualche trovata di Schoenberg, Webern o Berg, oppure per illustrare un particolare del proprio quartetto. Le dame dell’alta borghesia cittadina si sarebbero annoiate mortalmente, ma Gould, da furbacchione che era, inseriva ogni tanto qualche aneddoto divertente; così il suo pubblico, sempre in attesa del prossimo aneddoto, riusciva (appena) a stare sveglio. Dopo, ci fu un rinfresco nel foyer dell’auditorium, surriscaldato come tutti gli edifici pubblici americani nei mesi invernali; un amico comune mi presentò a Gould, e dovetti fare uno sforzo per non ridere quando lo vidi avvolto in un paltò chiuso al collo con una sciarpa. Egli riuscì – non so come – a bere un bicchiere di limonata con le mani guantate.
Ma la vita concertistica provocò in Gould dei problemi psicofisici al pari di quelli di Horowitz o di Benedetti Michelangeli. Cancellò molti concerti, e prima di quelli che non cancellò si somministrava generose dosi di tranquillanti e sedativi. «Mi tastavo il polso prima di ogni concerto – scrisse il pianista – per curiosità scientifica, ed era sempre molto veloce. Quindi c’era evidentemente una specie di agitazione anormale. Non ero paralizzato dalla paura, anche perché ero piuttosto indifferente a tutta la procedura. In verità stavo scontando gli anni, e il numero di avvenimenti contenuti in quegli anni, necessari per permettermi di dimenticare tutta quella storia. Credo che se avessi dovuto dipendere davvero, o se avessi saputo di doverlo fare per un periodo molto lungo, sarei rimasto così depresso che sarei stato assolutamente disperato. Lo ero comunque, fino a un certo punto».
E così Gould, nel 1964, avendo stabilito inequivocabilmente, come s’è detto, la propria reputazione artistica e guadagnato e investito bene parecchi soldi, smise di dare concerti davanti a «gente che sta lì, seduta, con l’odore del sudore di altre 2.999 persone nelle narici», come ebbe a dire. Dall’età di trentun anni in poi visse ritiratissimamente a Toronto, facendo ogni tanto una nuova registrazione discografica. Creò intorno a sé una muraglia di spiegazioni, oltre a quella dei 2.999 fetenti: per esempio, ripeteva spesso l’opinione che, quando si deve eseguire molte volte lo stesso repertorio davanti a platee diverse, si comincia a suonarlo senza fantasia – il che potrebbe anche essere vero per alcuni artisti, ma certamente non per tutti. Credo tuttavia che il motivo «più vero» fosse la summenzionata depressione che l’esibirsi in pubblico gli causò. Gould disse inoltre: «Col passare degli anni mi rendo conto sempre più spesso che riesco a far e a meno della gente; mi separo sempre di più da idee contraddittorie e contrastanti. La solitudine monastica funziona per me». Aveva certamente il diritto di sceglierla – e dato questo suo atteggiamento, è naturale che Gould considerasse la solitudine come «la condizione essenziale dell’eroismo. Non può sentirsi eroico chi non sia stato, prima, sprezzato dal mondo, o chi, forse, non ne sia stato lo sprezzatore».

Tutta la musica nella stessa persona
Gould diceva che le registrazioni discografiche permettono all’interprete e al produttore di scegliere l’ambiente acustico che desiderano, di raggiungere un grado di chiarezza impossibile nella sala da concerto, di esplorare le zone del repertorio che non attirerebbero un pubblico sufficientemente ampio da giustificare la loro inclusione nei grandi concerti e di portare miglioramenti a qualunque esecuzione tramite il montaggio di materiale preso da due o più riprese. Fin qui tutto bene. Ma forse Gould esagerava un po’ quando opinò che la moderna tecnologia stesse per creare «Un nuovo tipo di ascoltatore – un ascoltatore che partecipa di più all’esperienza musicale…» Per Gould questi giochi infantili rappresentavano un ritorno a un atteggiamento «pre-barocco» nei confronti della musica: compositore, interprete e ascoltatore riuniti nella stessa persona. Come se io, che amo la pittura ma non sono in grado di manipolare un pennello, togliessi la testa del Cristo da una foto della Resurrezione di Piero della Francesca e la incollassi sul corpo del Cristo di un’altra foto dello stesso dipinto – e poi aspettassi che qualcuno dichiarasse che sono riunite in me le capacità del pittore, del critico d’arte e dell’osservatore esterno.
Insomma, se Gould avesse semplicemente detto che non gli piaceva fare concerti e che preferiva fare dischi, nessuno avrebbe avuto niente da dire. Fu invece la pseudofilosofia che inventò per incolpare tutti quelli che non fossero dello stesso parere a trascinarlo in una palude verbale, dalla quale non sarebbe più emerso, e a costringere gli altri a dimostrare i punti illogici nei suoi discorsi. E i discorsi erano tanti, perché per quanto egli odiasse esibirsi, non poteva farne a meno: subito dopo il suo ritiro, incominciò a far parlare di sé tramite una fiumana di articoli e di trasmissioni radiofoniche e televisive. I suoi fans potevano seguire le sue idee sulla pubblica moralità e la regolazione del pianoforte, sulla vita nel Canada settentrionale e l’estasi, su Pablo Casals e la cantante pop Petula Clark, su Bach suonato dal sintetizzatore (gli piaceva) e Leopold Stokowski, sulla musica di sottofondo (la approvava) e Schoenberg, e su tantissimi altri argomenti. Alcuni dei suoi scritti erano intelligenti e divertenti, altri incredibilmente immaturi. Per i dirigenti della CBC (Radio-televisione canadese) Gould divenne un divo; a Toronto, dove vivevo anch’io all’inizio degli anni Settanta, un produttore radiofonico mi disse: «Tutte le sere, prima di coricarmi, prego Iddio che Glenn non mi telefoni alle tre di notte con qualche nuova e infantile idea per un programma».

Glenn Gould
La celebrità Gould la doveva alla sua genialità pianistica, non filosofica o sociologica o oratoria. E i pericoli del suo distacco dalle sale di concerto cominciarono presto a manifestarsi anche nel suo modo di suonare. Nei suoi momenti migliori Gould era musicista rapsodico: con naturalezza e sicurezza trascinava l’ascoltatore proprio nel cuore delle musiche che suonava. Quando 1a sua tecnica, la sua intelligenza e il suo istinto funzionavano insieme, il suo modo di fare musica aveva una qualità estatica che egli spesso descriveva come la conditio sine qua non dell’essere musicisti. Ma a volte, quella qualità spariva del tutto; per dimostrare che tutto è lecito, che tutto si può fare, a volte si serviva; di uno spartito come di un tavolo da gioco, e inventava le sue regole strada facendo. Abbandonava l’approccio rapsodico a favore di quello chirurgico: smembrava qualche pagina musicale per potercene mostrare, di questo o quell’altro pezzo le viscere. E col passare degli anni Gould, distaccato com’era dalla realtà della vita degli esseri umani che sudano e bisticciano e amano e odiano, questo metodo sterile le sceglieva sempre più spesso – col risultato che, per strana combinazione, le procedure di Gould, «musicista puro», cominciarono ad assomigliare a quelle di un virtuoso di vecchio stampo come Horowitz. Quale dei due ha detto: «Fa’ qualcosa con la musica! Potrebbe anche essere qualcosa che non ti piace, ma falla pure!»? È stato Horowitz, ma la sua dichiarazione non si differenzia molto dalle teorizzazioni, più contorte, di Gould.
Che ci resta, allora? Ci resta di godere quelle registrazioni di Gould nelle quali il suo genio prende il sopravvento sulle sue eccentricità. Bisogna sceglierle con cura, però. E ho riascoltato alcune recentemente ripubblicate su cd dalla CBS (la seconda versione [1981] delle Variazioni «Goldberg» di Bach, il primo volume delle Sonate di Mozart, il secondo volume delle Sonate di Beethoven, le quattro Ballate op. 10 e le due Rapsodie op. 79 di Brahms) e mi hanno lasciato perplesso e frustrato, esattamente come quando le ascoltai per la prima volta cinque, dieci, venti anni fa. Non c’è nemmeno uno di questi dischi che non contenga delle frasi affascinanti, delle trovate veramente geniali, da stimolare il cervello degli addetti ai lavori; ma per chi persiste nell’idea (ormai antidiluviana, lo so) che una interpretazione musicale, per essere convincente e coinvolgente, debba mostrare che l’opera interpretata sia qualcosa di più di una serie di particolari interessanti, non c’è nemmeno uno di questi dischi che regga.






